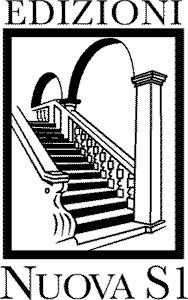| |
LA MOSTRA
Organizzatore:
Museo Storico Didattico della Tappezzeria "Vittorio
Zironi"
Curatrice:
Dott.ssa Francesca
Ghiggini Storico dell'Arte
Direzione generale:
Francesco Zironi
Progetto allestimenti:
Zironi Architetti
Con il Patrocinio di:
Comune di Bologna - Quartiere Saragozza
Partner:
Edizioni NuovaS1
Sponsor Tecnico:
Copisteria Collegio di Spagna
INTRODUZIONE
STORICA ALLA MOSTRA
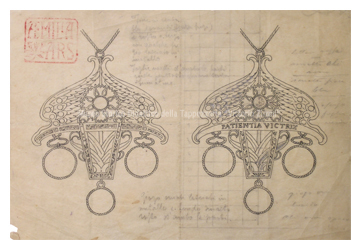 I
disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno
parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria
“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare
qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,
la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore
Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars. I
disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno
parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria
“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare
qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,
la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore
Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars.
Come è noto, la Società venne fondata a Bologna il 3 dicembre 1898 per
iniziativa di un gruppo di notabili ed intellettuali e con la direzione
artistica di Alfonso Rubbiani, allo scopo di riqualificare e dare nuovo
impulso alle Arti Applicate emiliane; la struttura originaria comprendeva
numerosi settori di produzione, tra i quali la gioielleria, che vennero
chiusi nel 1903, quando il presidente Francesco Cavazza decise di puntare
esclusivamente su quella che già si era rivelata “(...) prediletta dal
pubblico (...) cioè l’industria dei merletti e ricami a punto antico”.
La maggior parte delle immagini dei gioielli appaiono contrassegnate dal
timbro in inchiostro rosso o azzurro oppure dal marchio a secco di Aemilia
Ars; la firma di Alfonso Rubbiani non appare mai nei disegni ma il suo
acronimo o la sua sigla spesso appare nei cartoncini di supporto delle
fotografie d’epoca, mentre è più frequente la firma di Alberto Pasquinelli,
l’unico artista della cerchia di Aemilia Ars che, contrariamente a quella
che era la consuetudine della Società, appare attivo in questo settore.
Il ruolo di Rubbiani nella fase ideativa della gioielleria di Aemilia Ars si
è potuto comunque meglio definire per la presenza nello stesso fondo di
diciannove Schede descrittive manoscritte nelle quali si riconosce la sua
grafia, dove sono illustrate le fonti iconografiche, letterarie o storiche
di altrettanti disegni di gioielli, copiati da monili presenti in dipinti di
pittori del Rinascimento italiano, oppure ispirati a motivi figurativi del
passato, e definiti “Originale di Aemilia Ars - Tipo Rinascenza” e, infine,
di nuova concezione “Originale di Aemilia Ars”. Per la natura sintetica
delle descrizioni, spesso non è stato possibile riconoscere l’immagine di
riferimento e, inoltre, è certo che alcuni disegni furono dispersi in un
periodo non precisato.
Per la catalogazione di tutte le immagini sicuramente prodotte della Società
Aemilia Ars ma non citate da Rubbiani, si è però deciso di mantenere questa
divisione: sono stati quindi riuniti i disegni che presentano note
dell’autore che riferisce le fonti iconografiche o i pittori di riferimento,
le immagini dei monili che rivelano caratteristiche ispirate a motivi
decorativi del passato e, infine, quelle che seguono le tendenze più
innovative della gioielleria europea della fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento.
Nella prima categoria rientrano le immagini, i disegni e le fotografie
dell’epoca di questi , che replicano monili presenti in dipinti di autori
del Rinascimento, conservati nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, tra i
quali il già noto pendente esemplato sul gioiello indossato da Santa Cecilia
nella pala Estasi di Santa Cecilia di Raffaello Sanzio. Del pendente vennero
eseguite numerose redazioni, tutte conservate in collezioni private, ad
eccezione dell’esemplare di proprietà del British Museum di Londra, fino ad
ora attribuito all’orafo bolognese Luigi Marchi, titolare della ditta Luigi
Marchi e figlio. Ricerche condotte in occasione di questo studio presso
l’Archivio Storico della Camera di Commercio ed Arti di Bologna hanno
rivelato che, in realtà, Luigi Marchi decise di ritirarsi dall’attività
lavorativa nel 1895, per lasciare la ditta al figlio, Raffaele Angelo che,
pertanto, fu l’autore del monile e l’orafo di riferimento della Società.
Nelle Schede descrittive sono anche citati i due disegni che riproducono
preziosi presenti in due pale d’altare realizzate da Francesco Raibolini
detto il Francia, riconosciuti nella Pala Felicini e nella Pala de’ Manzuoli,
ancora conservate nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, e il disegno di un
pendente ispirato a quello indossato da Giovanna Tornabuoni nell’episodio La
nascita di San Giovanni Battista, svolto da Domenico Ghirlandaio nel coro
della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Sono stati inseriti in questa
categoria i bozzetti di due pendenti firmati da Alberto Pasquinelli: per uno
di questi, corredato da note che lo riferiscono ad un monile raffigurato in
un dipinto di Hugo Van Der Goes, non è stato possibile rintracciare il
modello di riferimento mentre il secondo, tratto “Da un quadro di Amico
Aspertini”, sembra richiamare la struttura del fermaglio del piviale
indossato da Sant’Agostino (o San Gregorio) nella pala Madonna con il
Bambino e i santi Agostino (Gregorio?), Nicola di Bari e Lucia, conservata
nella chiesa bolognese di San Martino Maggiore.

I disegni di pendenti che rientrano nella categoria “Tipo Rinascenza” si
sono in qualche caso rivelati ispirati ad opere, due decorazioni parietali
ma anche la Lampada Votiva della Pace dei Popoli, realizzate da artisti
della gilda di San Francesco su ispirazione di Alfonso Rubbiani durante i
restauri delle cappelle absidali della basilica di San Francesco a Bologna;
un monile, raffigurato in due fotografie dell’epoca, che presenta nel verso
un particolare dello stemma della famiglia Bevilacqua Ariosti di Bologna,
l’ala d’aquila piegata, mostra invece linee che richiamano un pendente
indossato da una delle Grazie rappresentate nel dipinto Allegoria della
primavera di Sandro Botticelli.
L’eclettismo che ha caratterizzato l’oreficeria italiana per tutto
l’Ottocento fino al primo decennio del Novecento è mostrato pienamente dalle
immagini dei pendenti che rientrano nella categoria definita “Originale di
Aemilia - Ars”. Le linee dei monili mostrano infatti l’influenza della
gioielleria francese Art Nouveau, ma anche un richiamo a Charles Robert
Ashbee, il più importante disegnatore di gioielli del movimento Arts and
Crafts inglese, mentre i disegni di due pendenti di soggetto dantesco,
ispirati ad altrettante terzine della cantica del Purgatorio, mostrano un
riferimento alla produzione di uno degli orafi italiani più innovativi del
periodo, il napoletano Vincenzo Miranda.
Nel paragrafo Altri disegni sono stati riuniti i disegni, bozzetti a colori
e fotografie d’epoca di gioielli, anche nella forma di medaglie celebrative,
e di una fibbia per cintura, spesso destinati a componenti della famiglia Cavazza: la cronologia presente, indicata dall’autore del disegno o
ricavabile dalle iscrizioni, va dal 1896 fino al 1930 ca. ma nessun
esemplare ricade nei termini di esistenza della Società.
Le note di esecuzione in corsivo presenti in alcuni, quali le medaglie a
pendente disegnate per celebrare il venticinquesimo anniversario del
matrimonio di Francesco e Lina Cavazza (26 aprile 1910), hanno permesso di
avanzare un’attribuzione ad Alfonso Rubbiani mentre i disegni di due
pendenti destinati alle consorti di due dei figli della coppia, Elvira
Belgrano Cavazza e Livia Colonna Cavazza, ancora realizzati in occasione
delle nozze, avvenute rispettivamente nel 1911 e nel 1930, si sono rivelati
la replica di esemplari realizzati dalla Società Aemilia Ars entro il 1903.
A cura Dott.ssa Francesca Ghiggini
|
|

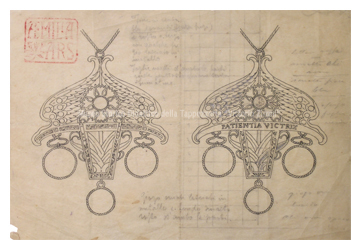 I
disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno
parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria
“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare
qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,
la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore
Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars.
I
disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno
parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria
“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare
qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,
la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore
Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars.